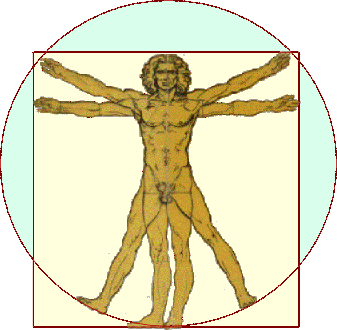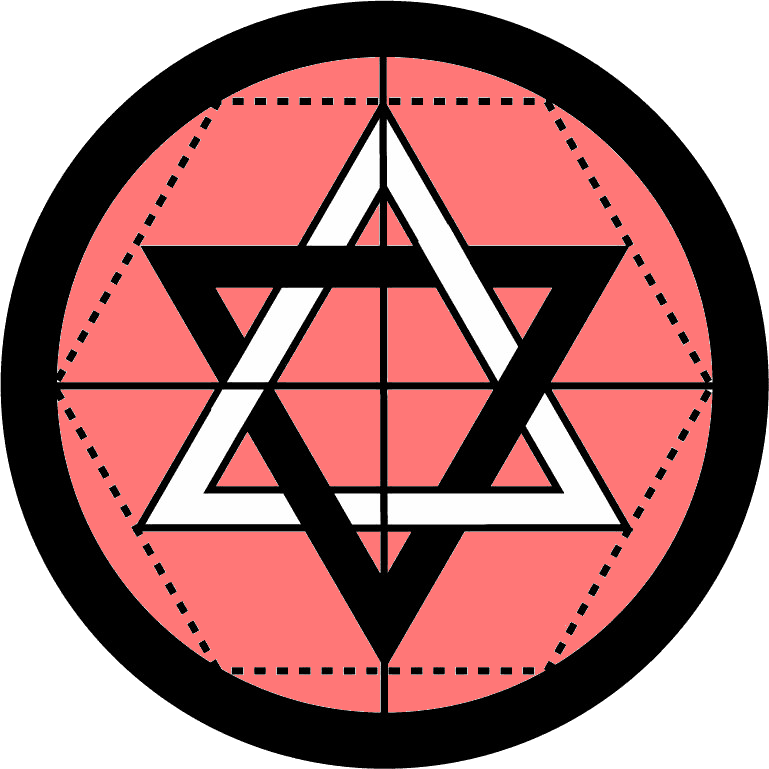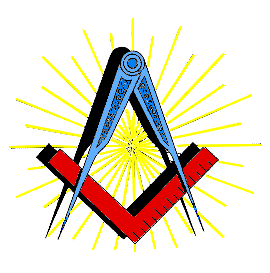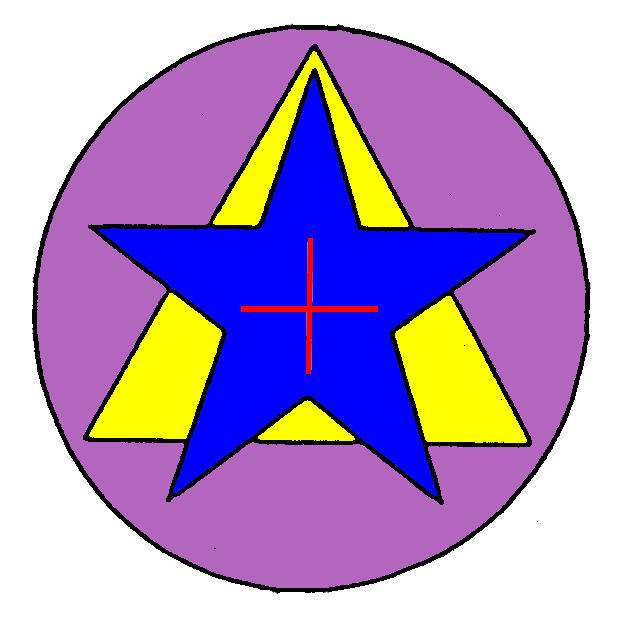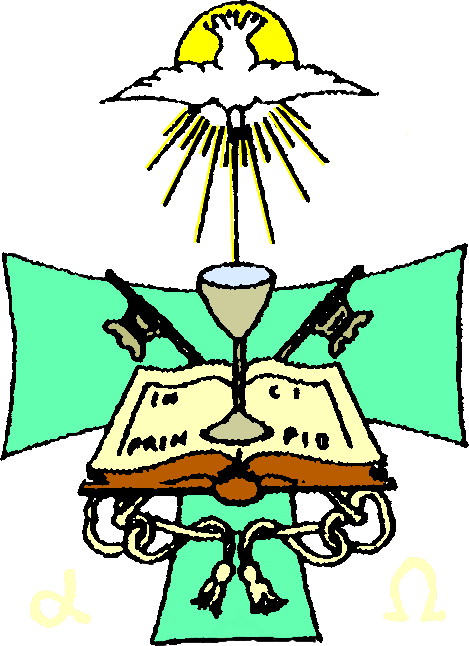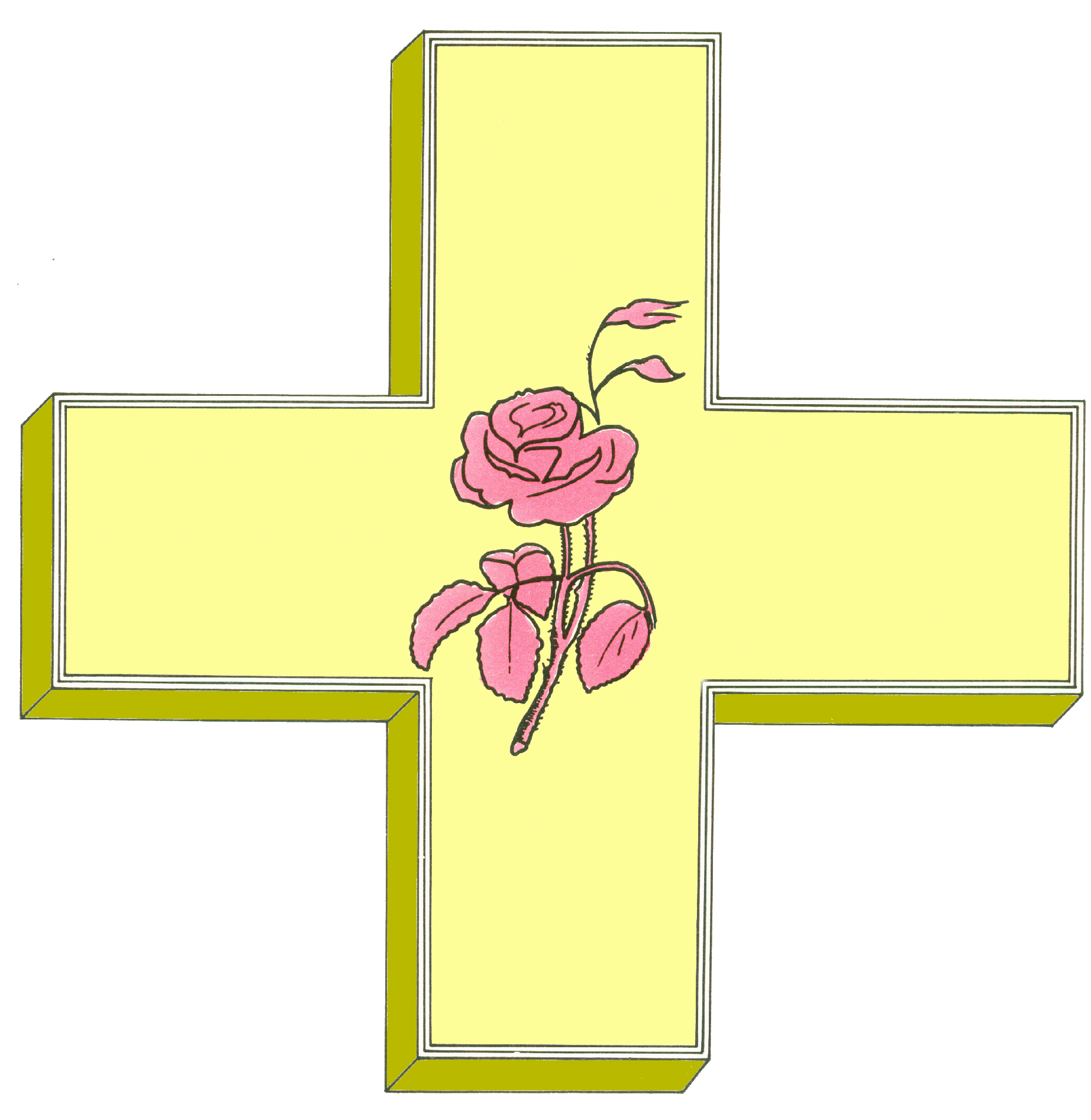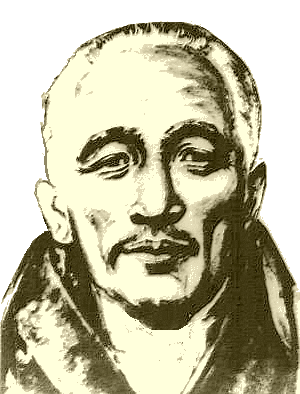|
IL
TEMPO RITUALE
E L'INFLUENZA DELLE FASI LUNARI
Igneus S:::I:::I:::
ORDINE MARTINISTA
IL TEMPO RITUALE
Negli ultimi tre secoli, ma soprattutto dalla metà del '700 in poi,
il calcolo, ma soprattutto la percezione del tempo è completamente
cambiata e negli studi rituali, come nell'operatività
magico?rituale, vi è la necessità di percepire la successione
temporale così come la concepivano gli antichi, una struttura
scandita in senso verticale (il tempo-i tempi-i tempi del tempo)
ritmata dai cicli inesorabili del sole, della luna, delle stelle,
delle stagioni e del lavoro che era ad esse sinergicamente connesso.
In questo modo vi era allora un tempo per ogni cosa, mentre adesso
non vi è più niente che abbia il senso del tempo. L'attuale
struttura del tempo, strumentale, meccanica, artificiosa, schiaccia
ed appiattisce l'uomo, che soffre nella morsa dei ritmi innaturali
imposti dall'attuale inciviltà e fra la pulsione di quelli naturali
che la sua natura biologica, psichica, intellettuale, spirituale,
abbisognerebbe. La scansione cronologica non è più indotta dal
rapporto micro/macrocosmico, dall'allineamento fra umanità ed
universo, ma da valori, necessità, interessi, bisogni,
tecnico/sociologici che, in astratto legittimi, si rivelano poi
disumanizzanti. Le problematiche legate all'uso del tempo rituale
non si risolvano unicamente con la conoscenza del tempo tradizionale
? che sarebbe relativamente semplice ritrovare ? in quanto, negli
ultimi secoli, sono avvenute profonde modificazioni biologiche e
biopsichiche dell'organismo umano (prodotte dalle implicazioni
psicosomatiche della variazione del tempo individuale).
La prima e più importante perdita è stata quella del tempo memoriale
o sociale, in seguito alla scomparsa dei mores che facevano sì che
la tradizione orale fosse nel contempo storia e mito, identità
individuale e sociale assieme. La mente, strumento dell'intelletto,
ha necessità di definire, di limitare la realtà fisica, di
concentrarne l'essenza in uno spazio mentale più puntiforme
possibile, proprio perché l'intelletto possa metaforizzarne e
simboleggiarne L'esperienza materiale, ritrovando l'indefinito e
l'infinito nell'astrazione metafisica. La memoria individuale è resa
quasi inutile dalla quantità e dalla rapidità delle informazioni,
spesso effimere e transeunti, e quindi labili, deboli, evanescenti.
Le incidenze interiori di questo processo sono di difficile verifica
logica, ma producono comunque una deconcentrazione ed un'alienazione
sia dalla realtà esterna che da quell'interiore.
Questa modifica biopsichica dell'entità fisiologica non può non
produrre nel contempo una modifica all'entità animica ad essa
corrispondente, con conseguente perdita di alcune facoltà intuitive
sui piani sottili che già l'umanità del medioevo conservava in
parte.
LA MISURAZIONE DEL TEMPO
NELL'ANTICHITÀ
Nel Duomo di Firenze esiste una rarità in assoluto, un orologio
meccanico il cui quadrante, diviso in ventiquattro eleganti
scomparti, è attribuito a Paolo Uccello: il Vasari nelle sue Vite
afferma che 'Fece Paolo, di colorito, la sfera delle ore sopra la
parte principale dentro la chiesa, con quattro teste ne canti
colorite in fresco". Il quadrante di Paolo è azzurro con al centro
un'unica sfera, imperniata al centro di una stella dorata, che si
muove in senso antiorario. All'equinozio di Primavera chi si
trovasse in Duomo alle 11,45 vedrebbe il braccio della stella nel
16' quadrante e resterebbe alquanto perplesso. La parte meccanica di
quest'orologio, di una complessità. incredibile nelle sue funzioni e
di una semplicità inaudita nella sua ideazione, viene caricata una
volta la settimana e marca il tempo secondo l'uso ebraico?cristiano,
in cui il vecchio giorno finisce (e nel contempo inizia il nuovo)
all'ora astronomica del tramonto, all'Angelus o Vespero detta anche
or di notte. A quest'ora le campane suonavano le ventiquattrore. Ma
con lo svolgersi delle stagioni anche l'ora del tramonto variava,
per cui con il variare delle stagioni bisognava rimettere i
quadranti. Prima dell'inizio dei secolo scorso, in cui sono stati
perfezionati gli orologi meccanici portatili, il mezzo più semplice
per regolare lo strumento cronometrico consisteva in un orologio ad
ombra solare e giù nell'epoca classica ve n'era una grande varietà.
Una vasta descrizione dei vari tipi di orologi solare ci è pervenuta
dalla fine del 1 secolo a.c. Le ore, come suddivisione duodecimale
dell'arco solare diurno e di quello notturno è di origine babilonese
e l'uso delle dodici ore diurne e delle dodici notturne è rimasto
generale, in Europa, fin dal tardo medioevo. In tal modo, per la
diversa durata del giorno e della notte nelle diverse epoche
dell'anno, queste ore erano di durata diseguale; le ore diurne
raggiungevano la massima durata intorno al solstizio estivo e la
minima attorno al solstizio invernale; le ore notturne seguivano,
ovviamente, la regola opposta. Tali ore furono dette temporarie e
quando, più tardi, caddero in disuso furono dette anche ore antiche
Nella bassa latinità si soleva però denominare soltanto cinque ore,
suddividendo il tempo diurno in quattro parti: l'ora prima (levar
del sole), la terza, la sesta (mezzogiorno) la nona e la dodicesima
(tramonto); a partire dal VI secolo la chiesa cristiana diffuse.
L'uso di dedicare tali ore a preghiere rituali (ore canoniche) e
così si introdussero termini come Mattutino (ora prima del giorno)
Vespro (tramonto) Compieta (ora terza di notte) e queste ore
venivano annunciate dal suono delle campane ed in tal modo,
soprattutto tramite le pievi, i ritmi temporali della giornata
potevano essere seguiti anche dalle popolazioni rurali. Già prima
del IV secolo la Chiesa aveva inoltre introdotto la regola di
iniziare il giorno civile con il tramonto del sole, innovando il
precedente uso romano di iniziarlo a mezzanotte. Ben presto poi,
privilegiando sul fenomeno naturale il momento della preghiera, per
la quale era più adatta l'ora dell'abbandono del lavoro dei campi,
in molte regioni si preferì spostare l'inizio del giorno a mezz'ora
dopo il tramonto, l'ora dell'Avemaria. Nel basso Medioevo il
diffondersi degli orologi meccanici pubblici, talvolta dotati anche
di campana a martello per battere le ore, portò all'affermarsi della
suddivisione del giorno civile (cioè del giorno inteso come somma
del tempo diurno e di quello notturno) in 24 ore uguali; uguali fra
loro e sempre uguali nel corso dell'anno. Tali ore furono dette
uguali o anche equinoziali perché alle epoche degli equinozi,
essendo l'arco diurno del sole uguale a quello notturno, ore
temporanee ed ore uguali hanno tutte la stessa durata e coincidono.
Il computo delle ore equinoziali dell'Avemaria della sera fu detto
all'italiana e le relative ore furono dette italiche; un precedente
antichissimo uso di contare 24 ore uguali o equinoziali dal sorgere
del sole fu detto alla babilonese. Successivamente, nell'ambito
dell'egemonia francese, si diffuse invece l'usanza di contare le
ventiquattrore uguali a partire dalla mezzanotte e tali ore furono
chiamata alla francese o europee o anche, dopo l'universale
adozione, ore moderne. Negli stati Pontifici, che tradizionalmente
furono sempre in ritardo nell'accettare le innovazioni scientifiche,
tale usanza fu introdotta solo nel 1846, da Pio IX. Lo sconcerto
popolare per tale novità ci è stato ben tramandato dal Belli, in un
sonetto in cui non sopportava che si dovesse "arimette l'orloggio
alla francese".
"Sto sor Pio come voì ch'Iddio li ajuti
Quanno ce viè a imbrojà pe li suoi fini
Sino l'ore, li quarti e li minuti?"
L'INFLUENZA DELLE FASI LUNARI
Le fasi della luna sono aspetti dell'illuminazione del disco lunare
dipendenti dalla posizioni della terra, della Luna e del Sole. Si ha
la Luna Nuova o Neumena o Novilunio quando la Luna si trova fra la
Terra ed il Sole e mostra la sua faccia in ombra, cioè non si vede.
Corrisponde alla congiunzione Luna-Sole. Si ha poi la Luna Crescente
che, passando per il Primo Quarto giunge fino alla Luna Piena (o
Plenilunio) corrispondente all'opposizione Sole-Luna. Abbiamo poi la
Luna Calante che, passando per l'Ultimo Quarto, arriva ad un'altra
Luna Nuova. La ritualità universale ha sempre dato una particolare
importanza alle fasi lunari in quanto vi è correlazione fra queste e
particolari variazioni psichiche ed animiche e dell'entità umana,
così come per la sua parte spirituale vi è relazione con il Sole.
Per gli usi rituali si possano sintetizzare queste variazioni,
secondo l'uso fenicio, nel seguente modo (sempre considerando che
l'azione della Luna è solo il riflesso passivo e notturno
dell'energia solare e che è proprio per questa qualità che può
interagire efficacemente con i piani sottili inferiori dell'uomo)
1a e 2a settimana lunare: Luna Bianca (o crescente) i
corpi sottili sono in fase espansiva (minore, naturalmente, nel
primo quarto) fino ad esprimere la massima turgidità e potenza nel
Plenilunio.
Questo periodo è adatto ad operatività espansive (di arricchimento
generico, acquisizione, sapienzialità, preminenza, predominio ecc.)
3a e 4a settimana: Luna Nera (o decrescente) i corpi
sottili sono in fase plastica, ciò che si opera in questi periodo si
imprime più facilmente (in modo minore, naturalmente, nel primo
quarto).
Questo periodo è adatto ad operazioni purificative e formative della
propria personalità esteriore ed interiore.
L'INFLUENZA DEGLI EQUINOZI E DEI
SOLSTIZI
L'enciclica, cioè il cerchio "disegnato" dal Sole durante il suo
moto apparente intorno alla terra, interseca l'Equatore celeste in
due punti: gli Equinozi (dal latino aequinoctiu, composto da l'ecquus"
(uguale) e nox, noctis (notte). Quando il Sole attraversa questi
punti, il 20/21 marzo, così (Equinozio di primavera) ed il 22/23
Settembre (Equinozio d'autunno) la durata della notte è uguale a
quella del giorno. L'Equinozio di Primavera, detto anche punto gamma
o punto vernale avviene 0° gradi in Ariete, mentre l'Equinozio di
Autunno si ha a 0° gradi della Bilancia. L'anno rituale inizia il
giorno in cui cade il I° grado di Ariete. Il Sole poi, nel suo
procedere lungo l'ellittica raggiunge due punti di massima
declinazione, sull'equatore celeste, uno a Nord e l'altro a Sud. In
questa posizione sembra sostare, star fermo per qualche giorno prima
di riprendere il suo cammino ascendente o discendente. Questi due
punti si chiamano solstizi (il termine e composto di "sol" (sole) e
dal verbo "sistere", fermare, fermarsi. Il punto di massima
declinazione Nord è il Solstizio d'estate che corrisponde a 0° gradi
del Cancro; il punto di massima declinazione Sud è il Solstizio
d'Inverno, corrispondente a 0° gradi del Capricorno. Le rispettive
date sono il 21 Giugno ed il 21 Dicembre, all'incirca. Gli Equinozi
ed i Solstizi sono i massimi momenti operativi nel corso dell'anno.
La loro natura rituale è analogicamente molto semplice in quanto
ripete alla massima esaltazione le influenze analogiche delle fasi
lunari. Ma questa volta la loro azione agisce sul corpo solare o
spirituale. Mentre le fasi lunari adiuvano, (secondo la fraseologia
martinista) la fase reintegrativa, quelle solari favoriscono la fase
trasmutativa, interagendo contemporaneamente.
TABELLA COMPARATIVA FRA LE FASI
LUNI-SOLARI
Equinozio di Primavera
Solstizio d'estate
Equinozio d'autunno
Solstizio d'inverno
Primo quarto
Plenilunio
Ultimo quarto
Novilunio
Operazioni di potenza -
Operazioni di potenza +
Op.ni di pur.ne e form.ne. -
Op.ni di pur. e form.
In questo quadro analogico si possano ritrovare le effettive
caratteristiche di ogni ritualità, a volte diversa nella forma, ma
sempre eguale nella sostanza e ricostruirne, se necessario,
l'effettiva originalità ed efficienza. Una caratteristica specifica
dei riti equinoziali consiste inoltre in quella di esser riti di
evocazione essendo gli equinozi le "porte d'ingresso", sia delle
influenze negative da esorcizzare, sia di quelle positive da
attrarre,6 sia interne che esterne. I Riti equinoziali dovrebbe
essere eseguiti entro l'ora postecedente l'inizio della fase. Più
correttamente, per l'Equinozio di Primavera, fra le 12 e le 13. Non
è da dimenticarsi che nell'arco temporale del rito vi sono dei ritmi
operativi secondo le armonie pitagoriche, che la tradizione ci ha
conservato, e, più precisamente:
1) la fase purificativa corrisponde alla sequenza massonica
3-4-5,
2) la fase reintegrativa a quella martinezista, 3-5-7
3) la fase trasmutativa a quella ermetica 3-6-9
Tratto dal sito Sixtrum
http://www.prometeolocri.net/
|